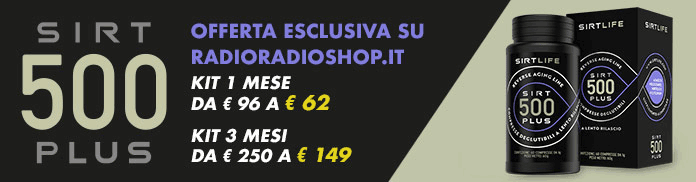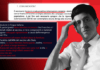Non è un luogo così preciso, nella memoria. Piuttosto, un qualcosa di sfumato, un battere incessante di tamburi che sale come una marea, che spinge su quadricipiti di ricordi, sempre una spanna più su di chiunque altro. Due sillabe da palleggiare in eterno, a battimuro verso il palato, come quando i genitori richiamano i ragazzini che giocano per strada, all’imbrunire, ma la partita non è ancora finita.
E non c’è più nemmeno una latitudine da precisare, quando basta aver posseduto un pallone per schiudere le labbra a quell’accento.
Un bambino con gli stracci da lustrascarpe ancora in mano ascolta una storia dal vecchio sorridente che è diventato: chissà se ancora si sorprende, o se sapeva già come sarebbe andata dal rumore che i cenci arrotolati facevano sul collo del piede scalzo. Nel fango lucido per le piogge stagionali, lo scintillio della prima Coppa del Mondo, dall’altra parte della povertà.
E arriva sempre qualcuno, ogni tanto, a dire che in fondo è soltanto un gioco; perché ci sono anche quelli che non fanno caso al colore dei fiori, agli occhi delle ragazze, al vento che tende le bandierine del calcio d’angolo. Non servirebbe a niente, tentare di spiegargli che Giotto ha indossato anche una maglia gialla, col cerchio sempre in equilibrio sul collo del piede.
Basterebbe fargli ascoltare i rimbalzi di una palla, via via più attutiti, che sembra ripetere due sillabe all’infinito.
Pelé.
Paolo Marcacci