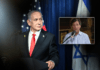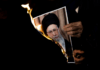La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto la pena inflitta ad Alessia Pifferi dall’ergastolo a 24 anni di reclusione. La donna era stata condannata in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo, abbandonata da sola in casa per sei giorni nel 2022. In quasi 200 pagine di motivazioni, i giudici hanno additato i media tra i responsabili della ‘metamorfosi’ della donna, individuando nel clamore mediatico uno degli elementi centrali per comprendere l’evoluzione del caso. Francesco Caselli e l’Avv. Giuseppe Di Palo hanno analizzato la questione in diretta.
Non un’assoluzione, ma un cambio di prospettiva
Non si tratta di una sentenza assolutoria né di una minimizzazione della gravità del fatto, che i giudici definiscono eccezionale e di estrema durezza. Si tratta, piuttosto, di una presa di posizione che sposta l’asse del giudizio dalla sola atrocità del gesto alla complessità della persona e del contesto che l’ha circondata, prima e dopo il delitto. Una scelta che interroga non solo il diritto penale, ma anche il ruolo dell’informazione e della spettacolarizzazione giudiziaria.
Nelle 193 pagine di motivazioni, la Corte afferma che il comportamento di Pifferi successivo alla morte della figlia non dimostra una particolare capacità a delinquere. Al contrario, appare coerente con una personalità ‘deficitaria’, fragile e immatura, ritenuta compatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Attenuanti che vengono giudicate equivalenti all’unica aggravante riconosciuta, quella del vincolo di parentela.
Marginalità sociale e lapidazione mediatica
A pesare sulla decisione sono una serie di fattori convergenti: l’incensuratezza dell’imputata, le gravi condizioni economico-sociali, l’estrema marginalità in cui viveva e, soprattutto, il violento impatto del clamore mediatico. Un’esposizione che i giudici non esitano a definire una vera e propria ‘lapidazione verbale’, capace di alterare comportamenti, percezioni e persino dinamiche processuali.
La Corte sottolinea come la pena non possa limitarsi a essere afflittiva, ma debba conservare una funzione rieducativa, soprattutto in presenza di una soggettività che non presenta tratti di abitualità criminale. L’ergastolo, in questa prospettiva, viene ritenuto una risposta sproporzionata rispetto alla reale pericolosità della donna, pur nella consapevolezza dell’orrore del fatto commesso.
Le testimonianze condizionate dalla pressione pubblica
Uno dei passaggi più duri della sentenza è dedicato al cosiddetto ‘processo mediatico’. Secondo i giudici, la trasformazione della vicenda giudiziaria in un prodotto televisivo ha avuto effetti ‘deleteri e devastanti’, interferendo con la valutazione delle prove scientifiche e condizionando le testimonianze. Il processo, scrive la Corte, è stato piegato alle logiche dello spettacolo, con la conseguenza di una narrazione semplificata e deformante.
La testimonianza prova lampante di questo è in riferimento alla madre dell’imputata, spinta dal timore dell’esposizione pubblica ad assumere un ruolo accusatorio e a riferire circostanze non veritiere. La sentenza si chiude con una dura condanna del processo mediatico, ridotto a intrattenimento televisivo, e con un monito che va oltre il singolo caso, richiamando la responsabilità dell’informazione quando la cronaca rischia di interferire con la giustizia.