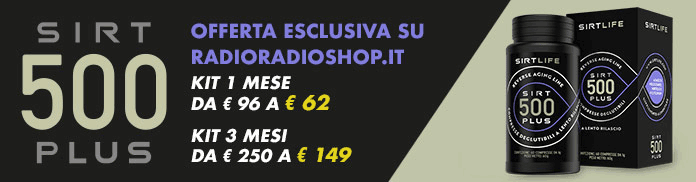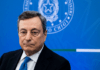Di Paolo Rossi si diceva che avesse un nome comune, come italiano, e un fisico ancora di più: la miscela ideale, apparentemente, per non passare alla storia.
Invece la storia se la prese, assieme ai suoi compagni di una Nazionale che meno parlava e meglio faceva; che aveva scelto il silenzio come unico strumento per fronteggiare due forme di dissenso: quello popolare e quello della stampa. Nel momento più impensabile, se la prese, ossia quando il girone dei quarti di finale del Mundial l’aveva messa, vaso di coccio tra vasi di ferro, in mezzo a Zico e Maradona. Mentre lui, che fino a quel momento aveva strusciato più bocciature che palloni, appariva spremuto ed emaciato sin dalle inquadrature dell’inno nazionale.
L’estate del 1982 ci aveva insegnato che almeno una volta nella vita tutto è possibile, anche per il Signor Rossi, tra i ghiaccioli e le fontanelle dell’ultima generazione di ragazzini che hanno giocato per strada; che dopo il due a uno all’Argentina e il tre a due al Brasile poteva giocare col Tango di gomma ancora tre partite intere prima che facesse buio, con le sbucciature nuove che fiorivano sopra le vecchie.
Sembrava troppo pesante, per le sue braccia magre, la Coppa del Mondo: qualche settimana prima, l’istantanea l’avremmo potuta ottenere soltanto attraverso uno dei rudimentali fotomontaggi dell’epoca.
Nel ripensare a tutto quello che è venuto dopo, nell’Italia del calcio come in quella della vita quotidiana, ti accorgi che quelli erano anche gli anni di una residua età dell’innocenza, già intaccata dal piombo e da troppi misteri, eppure ancora con in tasca figurine Panini e qualche briciolo d’ingenuità. L’avremmo capito e rielaborato meglio ventiquattro anni dopo, altra Coppa azzurra preceduta da scandali simili.
Trentotto anni dopo, nell’anno più strano e più stronzo, se permettete, ci ritroviamo orfani non di un’immagine da cartolina calcistica di un’epoca irripetibile, ma del francobollo che appiccicavamo, prima o poi, sopra ogni nostro discorso.
Paolo Marcacci