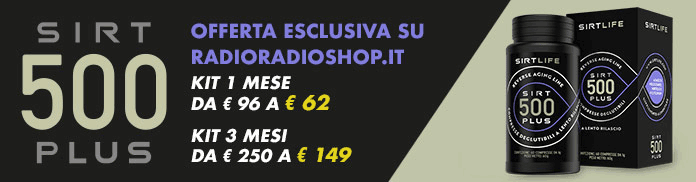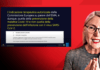Non va in scena il cattivo, questo deve essere chiaro da subito; del resto ce lo spiega lui, col suo malessere scandito da risate compulsive. Va in scena il disagiato, colui che è rimasto indietro, che per un motivo o per l’altro, magari per una serie di motivi tutti assieme, ha perso anche l’ultima corsa per il carro della rispettabilità.
Oh, certo, compie gesti o gesta, se preferite, da cattivo, in particolare in una scena quasi “splatter”, che sembra girata da un Tarantino con meno fronzoli.
Todd Phillips riesce nell’intento di plasmare non soltanto una storia; non solo un personaggio: la sua regia suscita più che altro un punto di vista, ossia quello che ognuno di noi è in grado di occultare nello sgabuzzino dell’anima, sicuro (e rassicurato) nel non dovervi mai ricorrere. Ad Arthur Fleck questo non riesce: è la sua condanna, la sua perversa libertà. Per questo, quando spara nel vagone della metropolitana o quando uccide in modo ancora più truce, in qualche modo sta dialogando con quella parte di noi che non presenteremmo nemmeno al migliore amico. Ammesso che sia il migliore; ammesso che sia amico. Joker deve farne a meno, perché è una delle privazioni che la vita gli ha imposto; altrimenti sarebbe rimasto Arthur Fleck, senza un un licenziamento a rammentargli la sua ennesima inadeguatezza, senza una pistola come appendice metallica al suo grido di dolore.
Il resto lo fa la bravura assoluta di Joaquin Phoenix, che a tratti quasi fagocita la sceneggiatura geniale.
Usciamo dal cinema riflettendo, fortunatamente per qualche istante soltanto, che Joker non è soltanto l’ipotetico inquilino dietro una qualunque porta, tra quelle che abbiamo accanto: Joker ci dorme dentro. Per fortuna quasi nessuno di noi lo sveglierà mai, convinti di non vederlo nello specchio soltanto perché non abbiamo il viso spalmato di cerone bianco, o decorazioni rosso sangue attorno agli occhi.
Paolo Marcacci
Leggi anche:
- 20 DOMANDE A CHEF RUBIO: Salvini, vegani, politica, chef stellati,…
- INTERVISTA ► Maurizio Costanzo
- Amore senza sesso, è possibile? Il parere della sessuologa
- “Le aziende portano in Italia cibi tossici” ► Parla il Vicepresidente di Coldiretti