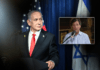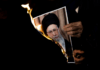In queste ore, leggendo ciò che circola in rete sulla tragedia di Crans-Montana, assistiamo a un rimpallo continuo di responsabilità. Da una parte ci sono i genitori di quei ragazzi, genitori devastati, che cercano comprensibilmente di difendere le scelte dei propri figli. E come potrebbero fare altrimenti? Perdere un figlio giovane – adolescente, tra i quindici e i vent’anni – è probabilmente la tragedia più grande che un essere umano possa affrontare, ammesso che si riesca a sopravvivere a un dolore simile. È naturale, umano, quasi inevitabile che un genitore, oltre al lutto, cerchi anche di proteggere se stesso da un trauma che rischia di distruggerlo.
Ma fermarsi a questo livello significa non voler vedere il quadro più ampio. Perché qui non siamo di fronte solo a una somma di errori individuali. Qui siamo di fronte a una società profondamente ferita, disorientata, psicologicamente fragile.
La domanda che dovrebbe inquietarci davvero è un’altra: come è possibile che dei ragazzi, in un contesto evidentemente pericoloso, invece di fuggire, filmino ciò che sta accadendo, arrivando a riprendere – inconsapevolmente – la propria morte?
No, non è colpa loro. E probabilmente non è neppure colpa dei genitori, né di chi gestiva il locale, che certo non desiderava una simile tragedia. Qui non c’è dolo. C’è ignoranza. Una ignoranza grave, diffusa, sistemica.
Ignoranza delle conseguenze. Ignoranza dei rischi. Ignoranza delle regole basilari della sicurezza.
Un’ignoranza che nasce dal fatto che non pensiamo più agli effetti dei nostri gesti quotidiani, perché abbiamo perso la consapevolezza di ciò che facciamo. Viviamo immersi in un flusso continuo di immagini, dispositivi, distrazioni che ci anestetizzano, ci sottraggono tempo, attenzione, esperienza reale. Il tempo che un tempo era dedicato a comprendere la vita, oggi viene divorato dagli schermi.
Quando noi boomers eravamo ragazzi, molte di queste cose ci venivano spiegate. Ci veniva detto che il fuoco, soprattutto in luoghi chiusi, è estremamente pericoloso. Che scintille e fiamme libere, a contatto con materiali non ignifughi, possono generare fumi tossici capaci di uccidere in pochi secondi, spesso prima ancora che le fiamme facciano il loro lavoro. Ed è esattamente ciò che è successo: molte vittime non sono morte bruciate, ma soffocate da gas letali.
Noi queste cose le sapevamo. Magari in modo semplice, elementare, ma le sapevamo. Sapevamo che “non si fa” e che, se qualcosa va storto, si scappa immediatamente. Oggi, invece, si riprende. Perché se lo fanno gli altri, allora non dev’essere pericoloso. Perché ci si fida ciecamente dell’ambiente, dell’organizzazione, dell’“istituzione”, che però ha smesso da tempo di educare davvero.
Provate a chiedere oggi a un ragazzo – anche a uno intelligente, anche a uno preparato – come funziona la combustione di certi materiali, cosa produce il poliuretano quando brucia, quanto rapidamente i fumi possono togliere conoscenza. Non lo sanno. Noi lo sapevamo? Forse non nei dettagli chimici, ma sapevamo abbastanza da stare lontani dal pericolo.
C’era il tempo per imparare. E soprattutto c’era l’interesse a proteggere la propria vita, non a documentarla per un profilo social.
Un tempo l’educazione passava anche attraverso esempi concreti. I genitori spiegavano come comportarsi nei luoghi chiusi, cosa osservare entrando in un locale: le uscite di sicurezza, gli spazi, i materiali. Persino in contesti come il servizio militare – al di là di ogni giudizio su di esso – venivano trasmesse regole di attenzione, di responsabilità, persino di protezione verso gli altri. Ci insegnavano a entrare in un luogo guardando, valutando, posizionandoci in modo da poter reagire in caso di pericolo. Ci insegnavano, in sostanza, a prenderci cura di noi stessi e di chi avevamo accanto.
Oggi, se fai questo, vieni spesso bollato come “esagerato”. Perché “tanto non succede mai niente”.
Ma il rischio c’è. E ignorarlo sistematicamente porta, prima o poi, a tragedie come questa.
Per questo fa male, anzi fa schifo, assistere alle discussioni online su “di chi è la colpa”. La colpa è dei ragazzi, dei genitori, dei gestori, delle istituzioni. No: la colpa è di tutti. Di un modello educativo che ha smesso di trasmettere il senso del limite e del pericolo. Di una società che ha sostituito l’esperienza con la rappresentazione. Di una cultura che confonde la libertà con l’assenza di regole.
Se non partiamo da qui, se non proviamo davvero a capire perché è successo e cosa fare per evitare che accada di nuovo, continueremo a piangere vittime, accendere candele, indignarci per qualche giorno. E poi, come sempre, dimenticare.