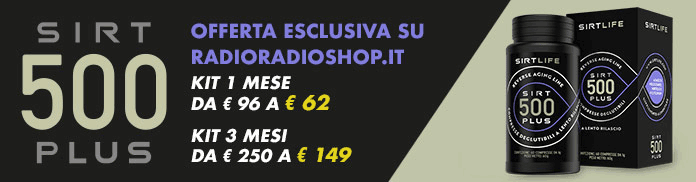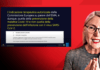Cominceremmo, anzi cominciamo da un distinguo, che rende giustizia a tutta una cultura, oltre che alla coscienza di un popolo: – Il tedesco dei campi non era il tedesco di tutti i giorni…anche da questo punto di vista la realtà dei lager era una realtà “altra”, parallela. – Lo disse e lo scrisse anche Primo Levi, del resto; lo ha ribadito stamattina Tatiana Bucci, reduce e superstite, assieme a sua sorella Andra, dal più indicibile abominio del ventesimo secolo. Davanti a una scolaresca, gli alunni della scuola media “Maria Capozzi”, durante un incontro tenuto presso una delle sale del cinema “Andromeda”.
– In fondo ero una bambina, alla fine degli anni trenta, che viveva la sua vita e tante cose non le capiva; non capiva come il mondo stesse cambiando attorno a lei; non decodificava la paura sul volto dei genitori, dei parenti, degli altri familiari e degli amici… –
Talvolta non tutto si riesce a trascrivere; questa vorremmo che fosse una di quelle volte, andando forse oltre il dovere di cronaca.

L’inizio, come una filastrocca terribile.
– Il quattro, quattro del quarantaquattro: la data del nostro arrivo ad Auschwitz – Birkenau. Sei anni io, quattro mia sorella Andra. Con noi il nostro cuginetto, Sergio. Eravamo assieme nel Kinderbloch, il blocco destinato ai bambini che sarebbero “serviti” per le sperimentazioni di Mengele e di altri – cosiddetti – scienziati suoi sodali. C’era una “blockova”, una delle prigioniere reclutate tra i criminali comuni, che fece in modo di proteggerci: un po’ di cibo in più, quando riusciva, qualche strato di stoffa supplementare da metterci addosso. Perché ricordo soprattutto il freddo, un freddo assoluto, anche se arrivammo all’inizio della primavera. –
La blockova in questione non allevierà soltanto le sofferenze dell’esistenza nel lager, per Tatiana, Andra e Sergio. Si adopererà per salvare loro la vita, confidando un segreto: non fare un passo avanti quando quel signore sarebbe arrivato a chiedere chi volesse rivedere la propria mamma. Quella mamma con cui Sergio viveva in simbiosi. Andra e Tatiana, che rimasero ferme alla fatidica domanda, avevano in qualche modo cercato di istruire anche Sergio, che non seppe resistere alla prospettiva di rivedere la madre.
– Fu l’ultima volta che lo vedemmo. –
Sergio, assieme ad altri diciannove bambini, costituiva uno dei venti “pezzi”, perché servivano venti “pezzi” utili per gli esperimenti. Finì i suoi giorni nella cantina di una scuola alla periferia di Amburgo il 20 aprile 1945, a pochi giorni dalla resa incondizionata della Germania. I giovani corpi erano stati brutalizzati dalle sperimentazioni, i cadaveri appesi a un gancio.
– Forse, per quanto ne so, quel signore giunto a fare l’appello poteva essere Mengele in persona; probabilmente era davvero lui… – ricorda Tatiana Bucci, con un tono di voce asettico, con il controllo ormai definitivo delle emozioni, che se possibile rende più terribile il racconto.
– E tutto quel fumo, quell’odore particolare, tutto il giorno, dal grande camino, che si disperdevano nel vento. Proprio come nella canzone di Guccini. E non sapevamo cosa fosse a bruciare di continuo, non potevamo nemmeno immaginare…
Tornate, Andra e Tatiana, a differenza di Sergio, dopo una serie di peripezie; dopo soste e cure trovate in più di un angolo d’Europa: tutte vicende raccontate nel loro libro.
E un’immagine, tra le altre, che lascia di sasso una platea di decine e decine di quattordicenni, mai forse così silenziosi, in vita loro, fino a questa mattina: – Un giorno qualcuno riuscì a farci avvicinare nostra madre, nel lager. Quando la vedemmo così magra, sofferente, senza più capelli e con solamente un po’ di stracci addosso, ci rifiutammo di avvicinarci a lei. Quando sono diventata madre io, ho ripensato migliaia di volte al dolore incommensurabile che devo averle provocato. Non riesco a perdonarmelo, ancora oggi. –
Paolo Marcacci