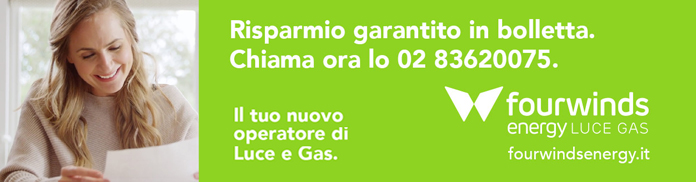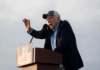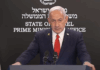Da sponde opposte, come è giusto che sia, ognuno mettendo in campo le proprie, legittime perché civili e divertenti, provocazioni, forse abbiamo realizzato un piccolo miracolo di civiltà, nella Capitale calcistica. Piccolo, per carità, forse anche esagerato come termine, perché in miracolo dovrebbe consistere di ben altra sostanza; però se ci guardiamo intorno, tra maglie sottratte ed esibite come scalpi, banane e ululati di risposta e altre lugubri manifestazioni da stadio – e da tastiera -, per una volta possiamo accorgerci del fatto che laziali e romanisti si sono affrontati sul terreno del garbo e del sorriso, col pretesto solenne del Natale di Roma.
Prima da sponde societarie, poi con la inevitabile cassa di risonanza delle due tifoserie, questa storia del “Caput Mundi”, a partire dalla maliziosa omissione biancoceleste, ha dato sfogo a ironie e giochi di parole e in tanti, compreso chi scrive, ci siamo divertiti a contribuire con le nostre trovate, più o meno riuscite, ma sempre sulle note leggere, anzi leggiadre dello sfottò civile, della trovata linguistica.
Vi pare poco? A noi no, stavolta, per una serie di ragioni riassumibili tutte nella povertà degli insulti, non solo calcistici, con i quali ci tocca convivere e che proprio per questo ci stanno apparendo sempre di più come la regola, quando invece dovrebbero costituire la deprecabile eccezione.
Per lo spirito di una certa romanità popolare ma raffinata al tempo stesso, sapida ma garbata nelle contrapposizioni, questo ha voluto dire riconoscersi in ciò che potemmo ancora riuscire a essere, se ci riconoscessimo per ciò che siamo stati per tanto tempo, diciamo sin dalle nostre origini. Ab Urbe Condita, per l’appunto.
Paolo Marcacci