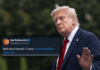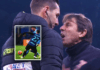Per decenni ci è stato insegnato a credere che i mezzi d’informazione fossero custodi della verità, arbitri imparziali tra fatti e opinioni. Un’idea rassicurante, ma sempre più lontana dalla realtà.
Oggi, sotto la spinta dei social media e del crollo dei modelli novecenteschi dell’informazione, questa narrazione mostra tutte le sue crepe. Il giornalismo che pretende di essere oggettivo non solo non convince più: appare sempre più come una finzione ideologica incapace di leggere il presente. La cessione del gruppo editoriale Gedi rappresenta un caso emblematico di questa trasformazione, come un asset da dismettere. La vendita delle sue principali testate – da la Repubblica a La Stampa, fino alle radio – non è solo un’operazione industriale, ma il segno di un fallimento editoriale e strategico: quello di un gruppo che non ha saputo rinnovare il proprio progetto culturale, né difendere davvero l’indipendenza e il pluralismo che proclamava.
Una vicenda che impone una riflessione profonda sul ruolo dell’informazione nel presente e sulle responsabilità di chi, per anni, ne ha guidato le scelte.
In diretta l’analisi di Boni Castellane.
L’informazione come spettacolo
L’informazione non è mai stata neutrale. È sempre stata, in forme diverse, uno spettacolo costruito con parole, immagini e selezione dei contenuti. Gli Stati Uniti, da questo punto di vista, sono stati più onesti: i talk show dichiarano apertamente la loro natura di ‘show’, programmi di intrattenimento fondati sul dibattito e sull’opinione. Che si tratti di Fox News o della CNN, la logica resta la stessa: non esiste una narrazione pura dei fatti, ma una loro messa in scena.
Il problema nasce quando questo spettacolo viene presentato come verità certificata. Quando il pubblico cerca nei media una specie di ‘agenzia di validazione’ – qualcuno che stabilisca cosa è vero e cosa no – spesso non lo fa per comprendere la realtà, ma per ottenere conferma delle proprie convinzioni. È un meccanismo psicologico prima ancora che mediatico.
Il mito dei fatti separati dalle opinioni
Il modello classico del giornalismo occidentale si fonda sull’idea che i fatti siano oggettivi e le opinioni vengano dopo. Per decenni la BBC ha incarnato questo paradigma, diventandone il simbolo più autorevole: prima i fatti, ritenuti innegabili, poi gli editoriali e i commenti.
Eppure questa separazione è sempre stata contestata. Già nel Novecento una parte significativa del pensiero critico – soprattutto negli Stati Uniti – sosteneva che i fatti non esistono mai ‘da soli’. Anche il modo in cui vengono selezionati, raccontati e gerarchizzati è una forma di interpretazione. In altre parole, l’opinione non arriva dopo: è già dentro la costruzione del fatto.
Gli eventi più recenti hanno reso evidente questa contraddizione. Proprio la BBC, il tempio dell’oggettività, ricordiamo che è stata coinvolta in uno scandalo clamoroso per la manipolazione di dichiarazioni di Donald Trump, montate in modo da farlo apparire come un istigatore di un colpo di Stato. Un episodio che ha demolito definitivamente l’idea di una neutralità possibile.
Il declino del giornalismo ‘certificatore’
Nonostante tutto, molti media continuano a presentarsi come detentori del buonsenso, della correttezza e del politicamente corretto. È il giornalismo del fact-checking permanente, che pretende di stabilire cosa si può dire e cosa no, e che squalifica come ‘falso’ o ‘pericoloso’ tutto ciò che esce dal perimetro ideologico consentito.
Questo approccio non solo è inefficace, ma è una delle cause principali della crisi economica dei grandi media tradizionali, che registrano perdite milionarie anno dopo anno. Un modello già obsoleto vent’anni fa, oggi appare semplicemente ridicolo agli occhi di un pubblico sempre più consapevole.