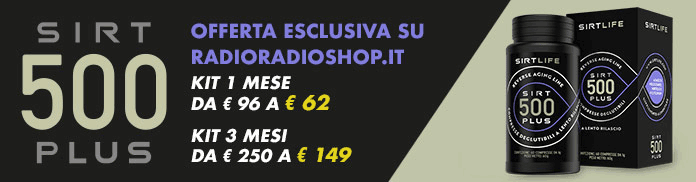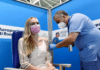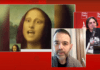Nessun “coccodrillo”, giornalisticamente parlando. Nessuna commemorazione. Solo il ricordo, più vivo che mai, della sua notte più grande.
Ci sono storie dalle quali nessuno dovrebbe uscire sconfitto, perché nessun vincitore sarebbe davvero tale se non si alimentasse della forza con cui il suo avversario tenta di annientarlo, a costo di trascinare anche se stesso all’inferno.
Quadrati di dolore, con una gloria puttana che se ne resta un passo al di fuori delle corde, in attesa di concedersi a quello dei due che alla fine alza i guanti verso un cielo di luci artificiali.
A Marvin non puoi non dirglielo, che è meraviglioso, perché lo ha fatto registrare all’anagrafe: allora non è più un aggettivo, o uno dei tanti soprannomi che quasi tutti i pugili tengono sotto la vestaglia; è un modo di essere e di vivere al tempo stesso; è un programma d’allenamento buono per uccidere chiunque non ne sia all’altezza.
Per tutte le miglia corse con gli anfibi ai piedi; per i sacchi di cemento portati a spalla in cantiere; per gli anni che ha dovuto attendere e per gli uomini che ha saputo stendere; perché un campione del mondo nero può anche aver bisogno di essere scortato dalla polizia, se ha appena tolto il titolo a un campione bianco, se persino Londra può rivelarsi intollerante, una sera.
Il fatto è che su quel tipo di trono non ci si sale mai per restarci a vita, perché nessuno te lo garantisce e la cintura, dal primo momento in cui ti abbraccia, devi mettere in conto che ti stia già dicendo addio. E la corona dei pesi medi a metà anni ottanta di aspiranti te ne ha tanti, forse troppi e a nessuno andrebbe negata. Non al Cobra, per esempio; non certo a “Mano di pietra”. Ma tu sei Marvellous, lucido nel cranio e prodigioso nella tecnica: un bisturi di cemento nel tuo gancio sinistro.
Da dove viene John Mugabi? Da un nulla ammantato di rabbia. E di stracci, gli stessi con cui si era presentato alla selezione olimpica per Mosca. Lo stesso anno del primo titolo mondiale di Marvellous.
Ugandese di Kampala, ragazzino analfabeta sotto la dittatura di Amin Dada, arrivato a Londra parlando solo lo swahili, anche se Don King giura di averci fatto una lunga chiacchierata. Come no.
Sei anni meno del Re, non un segno sul viso, punteggiato di barba rada, a incorniciare lo sguardo di chi aspetta da una vita; di chi avrà fame pure dentro una Cadillac, perché è la fame che lo ha fatto arrivare fino a qua: sul quadrato del Caesar’s Palace di Las Vegas, il 10 marzo del 1986.
Come Ali dovette specchiarsi nell’anima di Joe Frazier per risalire dagli inferi di una lotta sovrumana, così Marvellous sa, perché il campione lo sa sempre, anche se non lo dice nemmeno a se stesso, che Mugabi è la sua linea d’ombra: l’apice della sua gloria, il precipizio che potrebbe preludere alla caduta.
Mugabi sarebbe disposto a morire pur di prendersi ciò che gli spetta; Hagler darebbe la vita pur di tenersi ciò che ogni volta ha conquistato lasciando una parte di se sul fondo morbido inondato di sudore. Entrambi sarebbero disposti a uccidere, non è un modo di dire. L’uno perché sente che il suo momento è giunto; l’altro perché sente di essere ancora lui, l’uomo del momento.
La Bestia, John Mugabi, contro il Meraviglioso, Marvin Hagler, per il titolo dei Medi senza etichetta. Vuol dire il mondo, tutto, senza distinguo, senza sigle, meridiani o paralleli.
E allora il titolo è una preda, loro due felini con le unghie già fuori per metà dalla zampa: uno più possente, l’altro più flessuoso. Come se i guantoni avessero artigli.
Pensa a una celebrità, una qualsiasi, della musica, del cinema o dello sport e la troverai nelle prime file, con gli occhi sgranati.
Come fa a non squarciarsi la pelle che trattiene a stento i bicipiti di Mugabi, ogni volta che porta un attacco partendo col gancio sinistro? Quale torcia usa Hagler per trovare sempre la via sgombra per il suo jab destro? Programma di annientamento reciproco, messo in atto col fragore di colpi che atterriscono le star.
Perché la chiamano “nobile arte”, quando è un massacro condiviso? Te lo spiego con la sesta ripresa, che è manuale di sopravvivenza e d’estetica al tempo stesso; rappresentazione plastica lucidata di sudore; dolorosa anatomia, monumentale e sofferente nei saltelli ora più lenti e prevedibili.
È l’equatore del match, come se da questo momento in poi Hagler volesse attraversare un oceano di ritorno per riportare a terra il titolo e se Mugabi fosse invece un corsaro che ancora tenta di assaltare la nave con le braccia appesantite.
Eppure le braccia Mugabi comincia ad allungarle per trattenere il campione; catene immaginarie nei centimetri di distanza che tenta di accorciare, mentre Hagler gli sta piallando gli zigomi col jab, dopo aver riempito la cassa toracica come una stiva di sopportazione, per tutto ciò che di Mugabi se n’è andato addosso a lui.
Quel mondo che si stanno contendendo, entrambi ora lo vedono attraverso fessure di palpebre.
– Due riprese ancora, ti sto parlando come un padre! – dice all’angolo il manager di Mugabi, al termine della decima; conscio del fatto che il suo ragazzo ha dato tutto, mentre Hagler ha forse ancora qualcosa da prendere. L’intera posta, è il caso di dire. Torna sul quadrato col piglio di un giocatore di poker; guarda Mugabi in viso, ne coglie il velo che appanna lo sguardo; gli gira intorno, per quanto gli è ancora possibile. Poi, alla fine del secondo minuto dell’undicesima ripresa, cala sul tavolo un mazzo di quattro pugni, con gli ultimi due jab destri che hanno l’effetto del colpo d’ascia sul tronco già staccato. Basta guardare l’espressione di Mugabi, persa chissà dove, per capire una volta ancora che avrà sempre ragione Gene Tunney, per quando disse che il pugile al tappeto è l’uomo più solo al mondo.
Mugabi è stato magnifico, ma Hagler resta meraviglioso. Nessuno dei due, tuttavia, sarà più lo stesso dopo questa notte. Migliaia di cronisti, nel mondo, stanno contando assieme all’arbitro, mentre Marvellous è appoggiato alle corde, con l’aria di un signore che stia aspettando l’autobus.
Paolo Marcacci