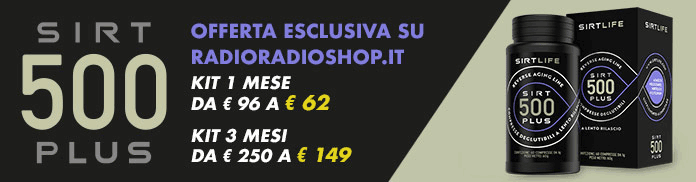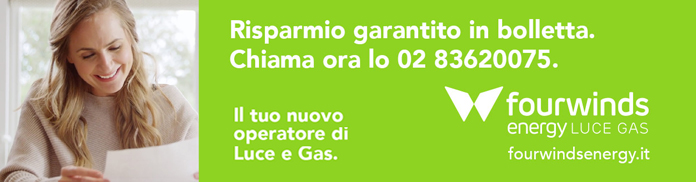Nascere a Isola d’Istria nel 1938, come dire venire alla luce con le stigmate del profugo, dell’esule. Un’Italia che dopo pochi anni non sarebbe più stata tale. Rinascere, una seconda volta, come atleta predestinato, nelle proporzioni e nelle movenze che in un corpo bambino costudivano già l’embrione del campione.
Nino Benvenuti è un paio di guantoni nel cuore del boom economico, ma è anche la bicicletta con cui doveva arrivare a Trieste per allenarsi: cinquanta chilometri prima di lavorare in palestra.
Un’Olimpiade negata, quella del 1956, soltanto perché il destino gli aveva steso il tappeto della gloria per quattro anni dopo: una bandiera italiana sotto un cielo dello stesso colore, a Roma ‘60. Nella custodia della Medaglia d’oro, una dedica autografata da Jessie Owens. Più della medaglia, se possibile, il trofeo Val Barker, che andava al pugile che si era mostrato tecnicamente più dotato del torneo. Benvenuti col suo stile la soffia a un mediomassimo che al Villaggio Olimpico già chiamavano “il sindaco”, tale Cassius Clay.
Persino imbarazzante stare a ricordare ciò che dopo sarebbe arrivato, perché non è soltanto storia della boxe, o dello sport in generale: è storia d’Italia, del costume della nazione. Racconta di nottate alla radio o di capannelli notturni davanti ai televisori monumentali col tubo catodico; di contrapposizioni tra Montecchi e Capuleti del tifo pugilistico per la sua rivalità, anche dialettica, con Sandro Mazzinghi: quest’ultimo combattente indomabile, Benvenuti artefice di una lotta danzante, di distanze cesellate dai suoi diretti d’incontro. E, a crescere, la narrazione varca l’oceano, perché la danza di Nino l’istriano strega lo sguardo dei giudici del Madison Square Garden, quando prende il via quella vera e propria trilogia del dolore, ci piace chiamarla così, rappresentata dai confronti con grande Emile Griffith.
Campione del mondo, nel mondo campione, Nino Benvenuti, testa pensante e scelte poco convenzionali, in un’Italia e in un tempo in cui all’atleta non si chiedeva certo di pensare, meno che mai di schierarsi.
Agli antipodi della sua boxe apollinea e impeccabile, tutta la rabbia dionisiaca di Carlos Monzon, affrontato e vissuto, nonché subito, all’apogeo di una carriera che contro l’argentino avrebbe conosciuto la fase discendente della parabola. Vissuta con stile, anche quella.
Buon compleanno, campione: per quelli come te gli italiani non hanno soltanto festeggiato grandi vittorie; si sono anche sentiti migliori.
Paolo Marcacci