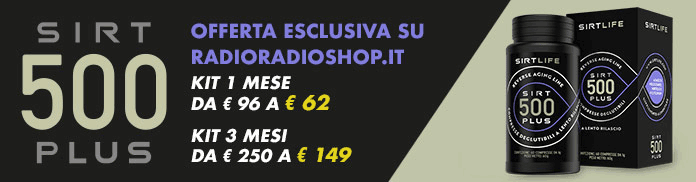A parere di alcuni economisti opporsi all’euro è l’unico segnale che oggi rimane ad un cittadino europeo per dichiarare il proprio dissenso verso il metodo paternalistico con il quale l’élite europea mette il popolo di fronte al fatto compiuto, è il segno più tangibile di questa politica e dei suoi fallimenti.
Il ciclo di deregolamentazione, in cui si inseriscono la vicenda europea e quella italiana, non è stato un successo. L’attacco attuato dalle élite transnazionali è riuscito a orientare a vantaggio di queste la distribuzione del reddito mediante, però, un modello di sviluppo che è fallito perché basato sulle logiche della finanza, logiche intrinsecamente di breve respiro, “disinteressate” razionalmente al lungo termine. Ed è proprio la miopia di questo modello a renderlo insostenibile finanziariamente, economicamente, socialmente e politicamente.
Questa insostenibilità si è palesata in una crisi in cui l’euro è un elemento amplificatore e il cui superamento non può essere delegato alle iniziative di un singolo Stato nazionale, bensì richiede un coordinamento e una cooperazione internazionali. Esattamente il contrario di ciò che ha imposto l’Unione Europea, in cui i valori di coordinamento e cooperazione sono stati sostituiti dalla promozione della legge del più forte e dalla filosofia del “tutti contro tutti”. Secondo un’analisi dell’economo A. Bagnai ci ritroviamo oggi con un cumulo di macerie delle nostre istituzioni sociali e delle nostre conquiste economiche.
Gli sconfitti sono molti.
In primo luogo proprio le istituzioni del libero mercato che, dopo aver rivendicato il primato tecnico e morale rispetto allo Stato inefficiente, si sono viste costrette a richiedere proprio a quest’ultimo le risorse necessarie alla propria sopravvivenza, risorse che rimpiazzassero quelle che esse avevano sperperato in giro per il mondo, sovvertendo lo stile di vita di intere popolazioni con il miraggio del “tutto e subito”e con il proprio short-terminism.
Non ne esce meglio lo Stato, che non si è dimostrato capace di sottrarsi alla cattura da parte degli interessi della classe sociale dominante e che per questo ha rinunciato a svolgere le normali funzioni di controllo ad esso devolute dagli ordinamenti democratici. Lo Stato che avrebbe richiesto una maggiore, non minore, regolamentazione e vigilanza e, in questo senso, le regole di diritto comunitario hanno avuto un impatto devastante.
Esce distrutta la politica, con la sua pretesa di poter tracciare scenari e visioni svincolandosi dal dato economico. Una sconfitta non dei singoli, bensì della collettività che, nel momento in cui ha acquistato coscienza della necessità di un ricambio, si è ritrovata come in Italia priva di personaggi non legati al precedente regime elitario e antidemocratico cui affidarsi per il cambiamento.
Ne escono massacrati i cittadini, nelle loro vesti di lavoratori sempre più schiacciati dal processo di precarizzazione, conseguente alla rottura delle catene di creazione del valore, la cosiddetta delocalizzazione. Ne escono sterminati i risparmiatori prima attratti e poi traditi dai facili guadagni e dalle rapide perdite del gioco delle bolle, e infine i consumatori sempre più indebitati nel tentativo di mantenere gli standard di vita precedenti allo shock. In Europa vi è stata la stretta ai diritti economici e sociali delle classi subalterne che stata accelerata dall’ultima crisi.
Il disastro economico a cui abbiamo assistito e di cui siamo ancora testimoni ha scosso dogmi della cui validità alcuni anni prima non era ammesso dubitare.
Il dogma della supremazia del mercato sullo stato ha iniziato a vacillare. A livello globale, la deregolamentazione finanziaria ha favorito una crisi debitoria epocale.
Il dogma dei poteri riequilibranti dei movimenti internazionali dei fattori produttivi che, spostandosi da un’area all’altra, contribuirebbero ad armonizzare le remunerazioni nei diversi paesi e ad attenuare le conseguenze di shock recessivi, è stato minato alla base dalla crisi. Nella pratica, la mobilità del fattore lavoro ha portato a ridurre l’offerta e la domanda di lavoro nelle aree di provenienza, conducendo altrove la propria spesa per beni e servizi, intrappolando coloro che sono rimasti in periferia alla logica dei propri mercati del lavoro a colpi di svalutazioni interne.
E’ vacillato il dogma dell’indipendenza della Banca centrale: tale ideologia, asse portante della deregolamentazione, viene ormai indicata come corresponsabile della catastrofe dalla stampa finanziaria. È ormai ammesso che l’aver attribuito totale indipendenza alle banche centrali ha portato, negli Stati Uniti e in Europa, a politiche monetarie eccessivamente espansive.
Nell’eurozona il riferimento ad un obiettivo d’inflazione, calcolato come media ponderata fra la bassa inflazione dei paesi del centro e l’alta inflazione dei paesi della periferia, ha condotto la Bce a praticare politiche troppo espansive perché tarate sui bisogni dei paesi più virtuosi. E così la periferia, mentre vedeva esplodere i propri tassi d’inflazione per l’attivarsi del ciclo di Frenkel, si trovava anche a godere di credito a buon mercato, premessa dell’esplosione delle varie bolle.
E’ crollato il dogma della competitività e il mercantilismo: trovare nelle esportazioni nette la chiave del successo economico di un paese fa sì che se tutti fossero esportatori non ci sarebbe più domanda. Questa semplice impossibilità logica, denunciata in particolare da Krugman, condanna le strategie di crescita mercantilistica al fallimento.
Se la strategia aggressiva tedesca dovesse essere giusta, e quindi l’intera eurozona dovesse competere con gli altri attori globali in termini di esportazioni, si porrebbe un problema di compatibilità. Da un lato, un’eurozona esportatrice netta forzerebbe aree meno avanzate a diventare importatrici nette, dall’altro un eventuale surplus europeo sarebbe comunque incompatibile con l’affermazione dell’euro come valuta di riserva in sostituzione del dollaro, in quanto una fuoriuscita netta di valuta da un paese corrisponde ad un’acquisizione netta di beni, quindi l’eurozona dovrebbe accettare di essere in deficit verso il resto del mondo.
Alla luce di tali considerazioni, questa crisi richiede un cambio di paradigma che deve muoversi dal superamento degli errori del vecchio modello e da una percezione chiara dei problemi da affrontare.
Poiché il ciclo della crisi è sempre innescato dal debito estero, bisognerà passare da una politica economica incentrata sul pareggio dei conti pubblici ad una focalizzata sul pareggio dei conti esteri, cioè da un Fiscal Compact ad un External Compact. Bisogna, quindi, adottare un modello di sviluppo basato sulla domanda interna.
Per attuare ciò, è essenziale che lo Stato si riappropri, in particolare, della politica fiscale, oggi intaccata dall’indipendenza della Bce, e della sovranità monetaria, esercitando il diritto di finanziare con moneta il proprio fabbisogno, diritto dal quale consegue la possibilità di finanziarsi a tassi che non rendono insostenibile qualsiasi politica fiscale anticiclica.
Infine, occorre che lo Stato si riconquisti lo strumento valutario, in quanto il riequilibrio dei conti esteri, dove la crescita viene rafforzata a favore delle componenti interne della domanda, è ostacolato dalla rigidità del cambio. Contemporaneamente la politica fiscale dovrebbe, nel breve periodo, stimolare l’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio pubblico, la messa in sicurezza del territorio e la normalizzazione dei percorsi di carriera dei membri della pubblica amministrazione.
Queste misure devono avere come obiettivo aggiuntivo quello di rilanciare l’occupazione, riportando il tasso di disoccupazione al di sotto del 6%, riattivando il tessuto economico del paese, tramite l’investimento massico in infrastrutture. Nel medio-lungo periodo, invece, tale politica dovrebbe finanziare e gestire misure che favoriscano una vera e propria crescita sostenibile che riporti la competitività del paese al livello pre-crisi.