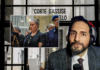In Italia torna al centro dell’attenzione il tema della compatibilità tra funzioni giurisdizionali e impegno politico. La questione è semplice nella sostanza ma complessa nelle implicazioni: chi esercita poteri di giudizio o controllo sulla spesa pubblica deve essere — e apparire — imparziale. Quando la militanza politica si affianca o segue da vicino incarichi in magistratura, il rischio di opacità cresce, insieme ai dubbi dei cittadini.
Il punto critico riguarda soprattutto tre aspetti. Primo: l’uso dei social in chiave militante da parte di figure investite di ruoli di garanzia. Toni aggressivi, inviti all’ostruzionismo o alla “guerra” politica mal si conciliano con la terzietà richiesta a chi giudica o vigila sui conti dello Stato. Secondo: la pratica dell’aspettativa con successivo rientro. La possibilità di alternare carriera politica e funzione giurisdizionale, senza una cesura netta, alimenta perplessità sull’autonomia delle decisioni future. Terzo: la sovrapposizione tra competenze tecniche e incarichi di alta sensibilità istituzionale. Anche quando non si tratta di giudici togati, ma di consiglieri o componenti di organi di controllo, l’apparenza di neutralità è decisiva tanto quanto la sostanza.
Resta un dato di fondo: l’etica della terzietà non è solo un adempimento formale. È la condizione che preserva la credibilità delle istituzioni. L’antico adagio sulla “moglie di Cesare” riassume l’esigenza contemporanea: non basta essere indipendenti, bisogna anche apparirlo. Senza una linea di demarcazione netta tra appartenenza politica e funzioni di garanzia, il conflitto d’interessi continuerà a erodere la fiducia dei cittadini e a indebolire, sul piano sostanziale e simbolico, lo Stato di diritto.
L’analisi del Prof. Maria Antonio Rinaldi