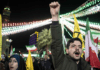Ciò che più colpisce se guardiamo ai tetragoni regimi del ‘900 è il fatto che essi siano stati possibili anche grazie all’agire quotidiano di uomini che si prestavano a compiere quelle atrocità.
Uomini che erano padri di famiglia, e che prima di recarsi al campo di concentramento a suppliziare le vittime, suonavano una sinfonia di Beethoven, o magari amorevolmente accarezzavano la testa dei propri figli. Il regime genera una sorta di distanziamento completo, di indifferenza che porta l’individuo ad essere indifferente o addirittura a godere delle atrocità che commette ai danni di chi non può difendersi, di chi è vittima inerme davanti alla violenza.
E’ una costante, dicevamo, dei recimi novecenteschi; e lo è purtroppo anche del nuovo regime terapeutico che stiamo vivendo da un anno.
Il regime, cioè, che chiamo protettivo. Quello che per proteggere la mera vita dal contagio ci toglie la libertà, sopprime i diritti e ci costringe a vivere compressi nel nostro corpo biologico sacrificando ogni altra istanza.
In sostanza quello che viviamo è un distanziamento sociale che si spinge al di là della semplice norma del metro di distanza che bisogna tenere dall’altro per evitare il contagio.
E’ un distanziamento che riguarda gli affetti, i sentimenti; quasi come se l’altro ormai fosse percepito e vissuto sempre e solo come un untore, come un appestato, come un virus rispetto al quale occorre immunizzarsi.
“Homo homini virus” è la nuova formula che caratterizza il capitalismo terapeutico.
L’altro non è più un compagno, ma un virus. Non è più un socio, ma un appestato, e dunque occorre immunizzarsi rispetto all’altro che viene puntualmente vissuto come un nemico.
La religione del capitalismo terapeutico ci chiede di amare il prossimo estromettendolo dalla nostra vita, di essergli vicini distanziandolo, di amarlo escludendolo dalla nostra vita.
Si crea così una mole immane di indifferenza, di “adiaforia” (direbbero i filosofi stoici).
E’ solo in questa chiave che si può leggere quanto accaduto a Porto Recanati, nelle Marche, secondo quanto riportato da “La Stampa” in data 30 gennaio 2021: “Covid, beve caffè in un locale: multato disabile di 58 anni in carrozzina. E’ avvenuto a Porto Recanati, l’uomo: avevo freddo, volevo riscaldarmi“.
Sarebbe davvero curioso guardare in faccia coloro che hanno multato un disabile di 58 anni in carrozzina, reo di aver preso un caffè in un locale per evitare il freddo. Siamo davvero di fronte a una spietatezza che non coincide semplicemente con l’indifferenza, ma che racchiude al proprio interno qualcosa di ben più pericoloso, qualcosa che forse sfocia talvolta nella volontà di nuocere al prossimo secondo un’asimmetria di potere che è ormai sotto gli occhi di tutti.
Il principio della nuda e cadaverica adesione alla legge “costi quel che costi” tende a produrre una montagna crescente di ingiustizie e di soprusi. Del resto era noto a Sant’Ambrogio che se la legge è al servizio dell’ingiustizia diventa semplicemente la leva della massima ingiustizia a norma di legge.
La storia del Novecento ce l’ha insegnato: le leggi ingiuste, se vengono rispettate, generano ingiustizia, non certo giustizia.
Sotto questo riguardo vi sarebbe da aprire una riflessione seria, non soltanto giuridica ma anche filosofico-politica.
Sono davvero degne di essere rispettate le norme che da un anno caratterizzano la vita, se ancora vita si può definire, quella entro i confini blindati del nuovo leviatano terapeutico?
RadioAttività, lampi del pensiero quotidiano – Con Diego Fusaro




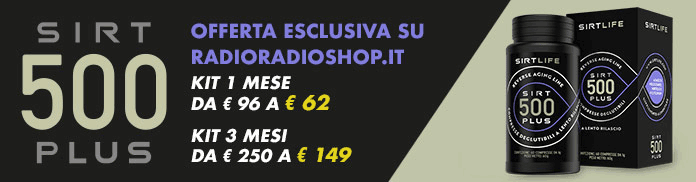







![L’archiviazione di Speranza contraddice perfino l’EMA ▷ “Ora si chieda la riapertura delle indagini” | [Parte 1]](https://www.radioradio.it/media/2024/04/Untitled-Project-68-100x70.jpg)