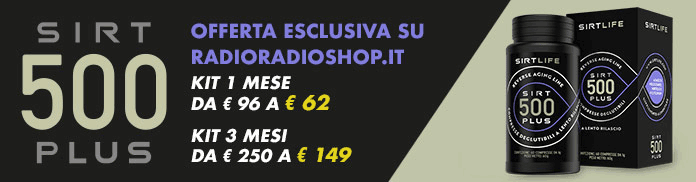Questa è una storia, come molte altre, sulla metamorfosi. Il cambiamento che si compie quando si definisce la propria persona o la propria poetica, per trovare il proprio tratto, o, come in questo caso, la propria inquadratura fotografica. Spesso accade di distrarci, ed ecco che da una via si sceglie un altro percorso fino ad allora mai considerato (come nei sentieri di Borges ci si perde e si prendono strade a volte facili e di buon auspicio, altre strette, dolorose e obbligate).
In principio Valerio Polici si avvicina a un’arte (spesso confusa con la “street art”) conosciuta come ‘writer’: un fare artistico ‘fuorilegge’ che fonda le sue radici nella città, soprattutto in relazione ai treni (con interventi nelle metro e nelle stazioni ferroviarie).
Il bisogno di trovare la propria ‘tag‘ e di completarla spesso con un numero significativo (che in principio richiama il proprio civico o l’età, o ancora, l’anno di nascita ecc.) appartiene a giovani autori allora inconsapevoli di dare il via a una corrente artistica che di lì in poi si svilupperà e si declinerà ulteriormente in altre correnti, alcune più vicine alla politica e con un chiaro intento di dire la propria (come per esempio la “street art” o “urban art”).
I ‘writer’ si esprimono attraverso il segno, con una gestualità e una padronanza del colore che eleva le firme a composizioni astratte da poter leggere e interpretare a diversi livelli. È interessante soffermarsi sul supporto scelto, perché scrivere sui treni significa anche far viaggiare la propria ‘tag’: la scrittura si muove e collega autori in diversi quartieri e città.
Dal movimento perpetuo delle scritte sulle linee dei treni Valerio Polici inizia a osservare attentamente il percorso labirintico dei writer per arrivare al proprio vagone: si parte mettendo fuori gioco le telecamere di sorveglianza per poi addentrarsi sotto terra, attraverso scale e cunicoli e tunnel e rotaie dei binari. È in atto la prima metamorfosi e il video è lo strumento utilizzato dall’artista per testimoniare il tragitto.
Valerio Polici registra con una camera portatile, maneggevole. Sono camminate notturne, dove non è permesso stare e l’uso della torcia, che illumina parte dell’ambiente circostante, è d’obbligo.
Il risultato è la somma di numerosi corti di un vagare senza fine in corridoi angusti e vertiginosi. Non ci sono ritratti (perché non bisogna lasciar traccia di chi infrange i limiti), ma solo spalle, mani, nuche, volti coperti e corpi che saltano o si abbassano per trovare e creare una via in una foresta sotterranea fatta di tubi di cemento armato e sgocciolamenti perpetui.
Fra i bivi e le curve nasce poi la necessità di fermare il tempo in un ‘frame’. Il passaggio dal video alla foto segna la seconda metamorfosi di un autore che sta scegliendo la fotografia come mezzo espressivo della sua ricerca estetica. L’inquadratura immobilizza l’eterno vagare illegale nel labirinto, sembrerebbe che per trovare l’uscita bisogna fermare il moto perpetuo.
Le prime foto di Valerio Polici sono notturne e sono stampate in bianco e nero. Un po’ per caso, per gioco ma mai per scherzo, accade che il suo lavoro fotografico sia visto da esperti del settore editoriale di fotoreportage.
Si consolida ora la scelta della fotografia come strumento per scoprire e approfondire l’indagine estetica. Fra il 2013 e il 2014 nascono, dunque, le prime pubblicazioni per il “Washington Post”, il “Newsweek” e “L’Espresso”.
Il lavoro da cui parte questo ritratto d’artista, intitolato “Ergo sum”, forma un polittico irregolare, che si compone e ricompone secondo lo spazio espositivo. Nel 2016 questo primo progetto fotografico di Valerio Polici partecipa alla Biennale di Architettura di Venezia, a cura di Fabio Armao.
L’anno successivo è parte della mostra “Cross the streets” al MACRO di Roma a cura di Christian Omodeo. I video registrati (parte integrante di “Ergo sum”), sono montati con una colonna sonora fatta ad hoc nel 2017 dal gruppo “Audio invaders”, che reinterpreta il sonoro originario con delle melodie sotterranee e liquide.
Le foto non desiderano svelare un reportage sui retroscena dei ‘writers’ durante i loro percorsi, ogni inquadratura, infatti, ha un alto grado di ambiguità interpretativa: i soggetti ritratti non s’identificano immediatamente come ‘writers’ e, a un primo sguardo, neanche i luoghi sono facilmente riconoscibili. Quei sei anni, dal 2009 al 2015 (questo è l’arco temporale che coprono i lavori del polittico fotografico) fra l’Europa e il Sud-America (i luoghi dove sono state scattate), sono stati fondamentali perché hanno mosso un desiderio nell’autore verso la scoperta della sua inquadratura.
Credo potesse trattarsi di qualsiasi cosa includesse un cammino e un andare e immagino che la fotografia sia il filo d’Arianna, che conduce Valerio Polici verso l’uscita del suo labirinto. Le foto giocano fra loro in composizioni vertiginose, a volte concentriche. Il movimento e l’assemblaggio di più frame sono alcune delle caratteristiche essenziali per interpretare il suo lavoro: avvicinare più foto fra loro vuol dire creare delle connessioni al di là delle cornici (struttura della griglia che delinea ciascun pezzo).
Nelle relazioni fra le foto si focalizza l’ossatura stessa della ricerca dell’autore che realizza un’opera costituita da un insieme consistente di unità che si compongono sempre in maniera diversa, quasi a voler emulare un movimento d’immagini fisse.
Al di là del bianco e del nero c’è un terreno chimerico in continua dialettica fra il moto e il suo contrario ed è proprio questa tendenza all’impossibile che cattura lo sguardo.
Giulia Tanferna