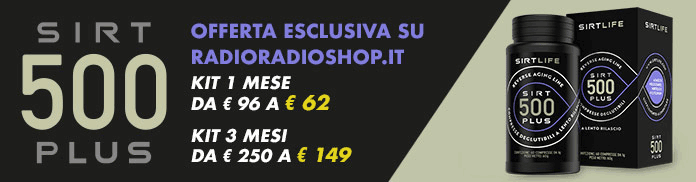1500 mutuati: né un morto, né un ricovero in terapia intensiva per la Dottoressa Maria Grazia Dondini, Medico di Medicina Generale a Monterenzio, in provincia di Bologna. Un bilancio ottimale le cui spiegazioni possono essere molteplici: bravura, preparazione. Tutto però comincia a cambiare dal 22 febbraio 2020, data nella quale in Gazzetta Ufficiale vengono promulgate dal Ministero le nuove linee guida per fronteggiare l’emergenza coronavirus che di lì a poco avrebbe sconvolto Codogno, la Lombardia, e in seguito l’intera penisola.
Il 22 febbraio è la data in cui il problema coronavirus inizia quindi ad esistere per il Governo, ma SarsCov2 si trovava in Italia da molto più tempo, e con ogni probabilità fino a quel momento era stato trattato dai medici di territorio, quelli che in seguito alle nuove direttive sono stati totalmente accantonati per far spazio ai ricoveri ospedalieri e alle terapie intensive.
Ecco perché, come ha spiegato a ‘Un Giorno speciale’, Maria Grazia Dondini non c’è stata: ha continuato a sentire e a curare i suoi pazienti nonostante le regole “non lo vietassero“, ma di fatto lo disincentivavano.
Preoccupazione, perspicacia e una certa dose di sfiducia nelle nuove regole del Governo hanno spinto la dottoressa a questa “ribellione”, anche perché come riferisce a Fabio Duranti e Francesco Vergovich, le nuove disposizioni “non andavano verso la tutela della salute, ma contro“.
Ecco l’intervista ai nostri microfoni.
“Forme febbrili accompagnate da una sintomatologia respiratoria le vedevamo già da prima di quel 22 febbraio . Da un certo momento in poi abbiamo dovuto dimenticare quello che avevamo fatto fino a quel momento perché trattandosi di un nuovo coronavirus la cui origine non era conosciuta e la cui terapia era inesistente, dovevamo fare denuncia di malattia infettiva al Dipartimento di Sanità Pubblica che prendeva in carico il paziente con una sorveglianza domiciliare, cioè il paziente doveva rimanere a casa fino al momento in cui l’insufficienza respiratoria non fosse stata tale per cui si doveva poi andare in ospedale.
Nell’ordinanza era scritto che doveva essere disincentivato l’accesso dei pazienti agli ambulatori di medicina generale, nei pronto soccorso e, in caso di sintomatologia respiratoria (che veniva ricondotta obbligatoriamente al coronavirus), i pazienti dovevano stare a casa loro isolati.
E’ chiaro che il Ministero non ha vietato la visita domiciliare, ma noi potevamo vedere i pazienti a domicilio, purché avessimo indossato la mascherina FFP2 che non c’era: la ASL mi ha fornito la prima mascherina il 30 di marzo.
Se i pazienti sono poi peggiorati? Certo. Non tutti perché poi ci sono forme febbrili che si vedono tutti gli anni che si risolvono spontaneamente. Il problema erano le complicanze: sono le infezioni batteriche che creano poi problemi e sono varie.
Ad un certo punto siccome si partiva dal presupposto che ci trovassimo di fronte ad una polmonite interstiziale, addirittura mi è arrivata una comunicazione dalla Regione in cui ci si diceva “non mandate i pazienti a fare la radiografia del torace, perché non è diagnostica per polmonite interstiziale”. Cioè se il medico aveva un sospetto diagnostico per esempio per una polmonite alveolare, non aveva la possibilità di una conferma diagnostica mandando il paziente a fare la lastra.
Sono state messe in atto procedure che sicuramente non hanno giovato alla salute dei pazienti.
Passavano 7-10 giorni prima che la situazione non fosse tale da richiedere il ricovero ospedaliero. I pazienti telefonavano al 118, gli chiedevano come stavano e se avevano un po’ d’affaticamento si rispondeva “aspettiamo ancora un po’”.
In coscienza io mi sono sentita di andarli a vedere questi pazienti: c’è un rapporto di fiducia. I risultati sono stati che – io ho 1500 assistiti – non ho avuto un decesso e nessuno è entrato in terapia intensiva.
Non sono la sola, anche una mia collega di Bergamo ha avuto gli stessi risultati.