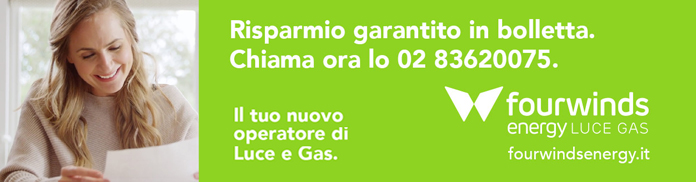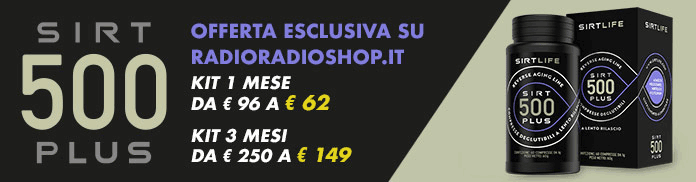Nell’articolo precedente ci eravamo lasciati con la seguente domanda: Esiste una convergenza economica tra Italia e Germania?
Andiamo per gradi. Che cosa si intende con il termine convergenza economica? In generale, si ha convergenza economica tra Paesi quando i livelli del PIL pro capite tendono, nel tempo, ad eguagliarsi attestandosi ad un livello comune che rappresenta l’equilibrio del processo di crescita.
L’obiettivo è stato, quindi, capire se oggi l’Eurozona, in particolare paesi quali la Germania e l’Italia, fossero arrivati ad un grado di convergenza tale che avrebbe confermato ciò che una parte della letteratura economica sosteneva, ossia la cosiddetta teoria dell’ “Optimum Currency Area o Optimum Currency Region”.Non voglio, però, fin da subito, svelarvi il finale di questa storia.
La storia la conosciamo. Inizia tutto con la volontà di alcuni stati, appartenenti a quella porzione del continente chiamato centro Europa, di unirsi prima economicamente e poi politicamente, col fine di lasciarsi alle spalle i numerosi conflitti condotti tra paesi vicini, che culminarono nelle due grandi Guerre Mondiali. La base di tale unione fu il Trattato di Maastricht in cui si affermava che tra i tanti compiti dell’Unione vi era anche la promozione di “un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di un’unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica”. Dalla sua ratifica sono trascorsi ben 27 anni e il detto “ne è passata acqua sotto i ponti” può calzare a pennello. In questo arco temporale c’è stato l’allargamento degli iniziali undici paesi aderenti, in particolar modo sul fronte dell’Est Europa, una bocciatura di una proposta di futura “Costituzione” europea, una modifica sostanziale del Trattato di Maastricht che ha portato alla nascita il Trattato di Lisbona. Come un fulmine a ciel sereno, nell’autunno del 2009 il neo primo ministro greco George Papandreou rivelò pubblicamente che i bilanci economici inviati dai precedenti governi greci all’Unione Europea erano stati falsificati con l’obiettivo di garantire l’ingresso della Grecia nella zona Euro, denunciando così il rischio di bancarotta del Paese.
Dall’alto delle istituzione europee, nel 2012, si è sentita la necessità di “mettere a dieta” la creatura, ormai cresciuta, Europa. La ricetta somministrava come medicina “Il Patto di stabilità e crescita”, cioè un irrigidimento del modello economico adottato dalla governance europea teso alla disciplina del bilancio mediante il raggiungimento del pareggio fra entrate fiscali e uscite di spesa. Constatata la natura ancora incompiuta dell’Unione Europea, tutti i governi dell’area euro hanno perseguito pesanti politiche di austerità nel disperato tentativo di rientrare nei parametri previsti, al costo di infliggere alla maggior parte delle economie e ai propri cittadini sacrifici cui tutti noi siamo stati testimoni.
L’ultima crisi economica globale che ha investito nel 2008 l’Unione Europea, evidenziandone le contraddizioni e i limiti del progetto, ha riportato in auge il controverso dibattito nato della teoria delle Aree Valutarie Ottimali, che risulta oggi, più che mai, attuale. Fondatore di tale teoria nel 1961 è l’economista premio Nobel canadese Robert Mundell, che descrive i criteri secondo i quali due o più paesi possono trarre convenienze economiche nell’abbandonare le loro monete nazionali adottando una valuta comune. Tale teoria costituisce una sorta di guidelinesdell’approccio economico.
Andiamo a volgere lo sguardo più da vicino prendendo in considerazione Italia e Germania, per analizzare e discutere come dal 2006 al 2015 i livelli di Pil pro capite per regioni si siano attestati su piani divergenti, ossia i loro differenziali siano aumentati esponenzialmente anche tra le regioni altamente competitive.
GRAFICO:
Pil pro-capite regioni italiane e lander tedeschi 2006-2015

Fonte dati: Eurostat 30.03.2017
Nelle posizioni più basse della tabella troviamo la regione Campania che si attesta addirittura su un valore negativo del -2,27 paragonato con un l’ultimo tra i lander tedeschi, Schleswig-Holstein che invece ha un differenziale del 20,80. Le domande da porsi sono la seguenti: Quali sono i motivi? Forse le politiche strutturale che si sono indirizzate a favore delle piccole e medie imprese per facilitare una ripresa economica non sono state abbastanza o non sufficienti? Siamo di fronte a un problema di differenziali produttivi come lo conosciamo noi a livello nazionale: un Nord, industrializzato e produttivo che traina, a fatica e malvolentieri un Sud, la periferia, arretrato e ancora rurale?
Se però guardiamo l’Abruzzo, la Toscana, la Basilicata e la Puglia risalta che il loro Pil si è attestato su un livello abbastanza ottimale, comparato con i valori di altre regioni italiani: andiamo a capire perché. L’Abruzzo è stata la realtà regionale che ha riscontrato la più alta crescita di start up innovative in tutta la Penisola: + 35,7% da fine 2015, su una media nazionale del 21,2%. Si registra che piccole imprese nel settore agroalimentare sono soprattutto giovani, molti dei quali riescono a vedere i risultati del loro sacrificio. Ovviamente, la strada da percorrere è ancora lunga, soprattutto per quel che riguarda le PMI che, nonostante i dati positivi, soffrono ancora di problemi infrastrutturali che andrebbero colmati. Come? Superando il provincialismo radicato nella regione, attivando e incrementando sinergie territoriali che sono la chiave per lo sviluppo delle piccolissime imprese.
La seconda regione italiane che regge l’impatto della crisi è la Toscana, con un boom di assunti nel settore della green economy, pensiamo che nel 2015 sono stati impiegati quasi 4.000 persone e c’è chi afferma dalla segreteria CGIL Toscana che le scelte in senso ambientale non sono un peso ma una straordinaria chiave per affrontare la crisi. Un’ economia verde che produce in Italia 102 miliardi di valore aggiunto- il 10,3% del totale-, crea quasi 3 milioni di posti di lavoro -13,2%-, con 372 mila imprese -il 24,5%- che dal 2008 a oggi hanno investito verde e hanno ottenendo così anche più credibilità sui mercati esteri. In Toscana le imprese che hanno investito in prodotti green sono 27 mila, Firenze è al settimo posto tra le prime 20 province italiane che ha optato per questo settore economico, con 8.000 imprese, il 30% del totale. Le assunzioni verdi sono il 12% del totale. Chi investe nel settore? Soprattutto l’edilizia dove c’è sempre più richiesta di costruzioni eco sostenibili e dove l’originaria nicchia di lavoratori verdi altamente qualificati si estende fino ai muratori. Anche le PMI toscane hanno dimostrato e dimostrano la loro capacità di resilienza in momenti di crisi. Ma il centro Italia non è l’unico, infatti in un articolo del Sole 24 Ore del novembre ’17 si è affermato che c’è stato un incremento anomalo di aziende meridionali in 10 anni di crisi. Si sostiene che dal Lazio in giù vi è stato il maggior saldo positivo di crescita imprenditoriale. Ciò, infatti, che colpisce è la maggior capacità di tenuta delle imprese del Centro e del Sud nel loro complesso, rispetto a quelle del Nord in tempo di crisi.
Potremmo così affermare che la piccola realtà imprenditoriale del nostro Paese sia resiliente nei momenti di shock, come il caso dell’Abruzzo o della Toscana, a differenza invece delle multinazionali, le quali sfruttano le economie di scala e sono più “utili” se ci sono cicli di crescita economici. Vista al microscopio l’economia italiana riesce a reagire, ma comparandola con quella tedesca la sua“buona riuscita” zoppica.
La domanda riecheggia: esiste una convergenza in termini economici tra Italia e Germania? Basterebbe con un semplice colpo d’occhio confrontare le variazioni di Pil tra le prime due regioni italiane, la Provincia autonoma di Bolzano e la Lombardia, e quelle tedesche, Baden-Württemberg e Berlino per capire immediatamente che un possibile paragone non può sussistere. I differenziali di Pil pro-capite per singole regioni pesano, soprattutto se le regioni che si prendono a paragone sono considerate economicamente le più “avanzate”. Il quadro descritto dipinge, passatemi il termine, non un’”Optimal area” bensì a “bad currency areas”.
Le vicende raccontate simboleggiano e testimoniano la forza e la volontà del tessuto industriale italiano. Non si può nascondere, però, che la recessione ha indebolito fortemente le PMI. L’Italia nello specifico sembra pagare alcuni problemi strutturali del suo sistema imprenditoriale. Da un lato, infatti, le PMI vantano una tradizionale ed elevata diffusione sul territorio e sono tutt’ora in grado di sfruttare le opportunità offerte da processi produttivi frammentati in settori maturi. Dall’altro, però, questa frammentazione viene pagata in termini di produttività e di capacità competitiva sui mercati.
Quindi, quali potrebbero essere i piani da adottare? Oggi, più che mai, diventa decisiva la scelta e l’applicazione di valide strategie di policy in grado di guardare al medio-lungo periodo: da un lato, infatti, le PMI necessitano di un adeguato e mirato sostegno capace di fronteggiare e diminuire gli effetti negativi, nonché di cogliere le opportunità di ripresa; dall’altro, è cruciale che vi sia un forte reindirizzo verso investimenti in grado di apportare un quid ad un sistema produttivo maturo quale quello italiano. Una strada da seguire potrebbero essere le politiche di sostegno alle piccole e medie imprese, il cosiddetto “Small Business Act”, che ha un impatto sulle caratteristiche strutturali di Stati ed estende il campo delle politiche attuate dai singoli paesi prevalentemente in funzione anticiclica. I suoi interventi si ricollegano a 5 ambiti: a) sostegno ai mercati, sviluppo delle competenze e innovazione; b) aiuto nell’accesso al credito e ai finanziamenti; c) creazione di una regolamentazione più snella ed efficace; d) sviluppo dell’imprenditorialità; e) misure per l’occupazione e politiche sociali.
In una panoramica globale, se si ritiene che l’integrazione economica europea sia un valore da perseguire, il percorso potrebbe essere quello di ricominciare dalle integrazioni delle economie reali: dei mercati del lavoro, dei sistemi previdenziali e di quelli educativi, mantenendo fra le economie nazionali quei presidi dati dall’autonomia delle politiche fiscali, monetarie e valutarie. Solo in questo modo si potrà riprendere quel cammino al termine del quale l’unione monetaria si presenterà come uno sbocco naturale e non traumatico. Un cammino che, probabilmente, richiederà molto tempo ma che è ormai ineluttabile, in quanto forzare le tappe sta rischiando solo di farci tornare indietro.
Roberta Novacco