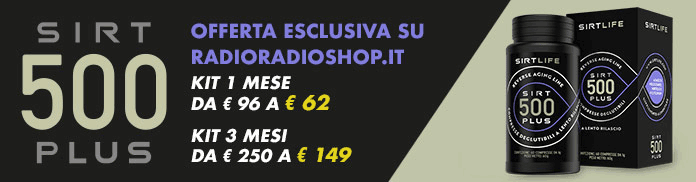I calciatori di qualche tempo fa avevano spalle come stampelle, toraci ossuti che ancora non esplodevano, sopra le gambe muscolose.
Erano benestanti senza restare mai ricchi del tutto; in pochi diventavano milionari, quando facevano cose straordinarie, come prendere per il collo una Coppa del mondo.
Erano figurine che spesso avevano i baffi, sguardi arcigni, sopracciglia folte. E qualcuna, fra le tante, ti veniva naturale metterla da parte, perché sapevi che l’avresti conservata. Per quale motivo? In nome di quella paradossale dignità che è uno dei sentimenti più nobili del calcio, ossia il fatto che il rispetto, raro, che provi per un calciatore che veste una maglia avversaria, sa essere a volte più intenso e in qualche caso assoluto rispetto a quello indotto, più naturale, che nutri nei confronti di un giocatore che indossa i tuoi colori.
Gaetano Scirea vestiva la maglia più detestata, per tutti quelli che non sono juventini; è quasi come se non ci avessimo mai fatto caso, come se quelle strisce bianconere, all’epoca sottili nell’intreccio del cotone semplice, addosso a lui diventassero persino eleganti, nella gestualità semplice di un rinvio, guidato dal profilo affilato, dallo sguardo nitido, rimasto per sempre timido nello specchio di ogni telecamera.
Oggi sono passati 33 anni dalla sua morte così casuale, così evitabile; di conseguenza così ingiusta e, a maggior ragione,” è sorprendente prendere atto della vitalità del ricordo e dell’importanza di Scirea. Più passa il tempo e più ci rendiamo conto di dover prendere atto di una cosa: l’esempio che ha lasciato sconfigge giorno dopo giorno la sua assenza.
Forse perché Scirea era innanzitutto uno sportivo. Noi che andiamo spesso a caccia di definizioni che colpiscano, aggettivi che restino impressi, ora ci rendiamo vinto che questa parola è quello che racchiude meglio l’essenza di un uomo come lui. Era un atleta partecipe, col suo modo di stare al mondo, dei valori dello sport: li aveva scelti e ogni giorno tornava a sceglierli con semplicità; se li portava in giro per il mondo, anche dopo averlo conquistato.
Con il suo sorriso contenuto, quasi da cercargli in viso; con il rispetto per qualsiasi avversario allo stesso modo che per qualsiasi compagno. Con l’educazione che esibiva nel parlare a chiunque. E poi con la capacità di ricordare, per ognuna delle sue tante vittorie, che vincere non vuol dire mai sentirsi superiori. Di conseguenza, nessuno mai dovette insegnargli a saper perdere, perché Scirea sapeva già che significa imparare dagli errori.
Perché Scirea era un uomo vero. Uno che ha saputo tenere e mantenere, costantemente, i piedi per terra. Non dimenticandosi mai, cioè, che suo padre e sua madre avevano avuto più di mezza vita scandita dalla sirena di una fabbrica, per un millesimo del suo stipendio e, quindi, meritavano più ammirazione e rispetto di quanto ne meritasse lui che, in fondo, era diventato ricco giocando a pallone.
Perché Scirea era un campione. Le qualità umane non devono distrarre dal calciatore, perché in fondo è una parte importante del perché lo ricordiamo ancora oggi. Scirea era un fenomenale calciatore, precursore di un calcio che viviamo oggi. All’anagrafe calcistica era “libero”, quello che oggi si definirebbe difensore centrale, e aveva strepitose capacità di lettura, anticipo e marcatura. Ma poi avanzava e allora lo trovavi agora da mezzala, meglio delle mezzali, o lo pescavi in area e segnava gol con movimenti da centravanti. Era un giocatore universale, dotato di intelligenza calcistica superiore e una tecnica di base eccellente, grazie alla quale non gli mancava nessun fondamentale.
Ecco perché ci piace ribadire questa cosa, ci teniamo perché un piccolo dubbio, sentendo i ragazzi di oggi rievocarne la leggenda, ci assale: non vorremmo che il ricordo giustissimo dell’uomo gentile e generoso, del calciatore corretto e pulito, del campione di civiltà, come ebbe a definirlo Sandro Ciotti, finisse per offuscare, nell’immaginario delle nuove generazioni, la grandezza tecnica di una difensore raffinatissimo, avanti anni luce rispetto al calcio della sua epoca: ai più giovani, che conoscono sicuramente l’Urlo di Tardelli, simbolo del Mondiale 82, nella finale del Bernabeu contro la Germania Ovest, consigliamo, senza stare tanto a ricamare con le parole, di rivedere quel gol e guardare come Scirea partecipò all’azione, di annotare il colpo di tacco esibito con naturalezza e l’assist nitido, di riflettere sulla scorribanda da difensore a cui venne naturale la percussione offensiva, benché l’Italia vincesse già uno a zero: un’azione che anticipava il futuro.
Chiuse nell’88 con un bilancio straordinario: 397 partite in Serie A, una serie di 148 gare consecutive, da Fiorentina-Juventus dal 1° febbraio 1981 a Juventus-Fiorentina del 1° febbraio 1985, che fanno quattro anni tondi senza saltare un turno. 87 partite e 3 gol nelle Coppe internazionali, comprese cinque finali vittoriose: la Coppa Uefa del ’77, la Coppa delle Coppe dell’84, la Supercoppa, la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale dell’85. Un primato mondiale. E, per gradire, sette scudetti e due Coppe Italia.
Cominciava una nuova vita, da tecnico, quando una vampa di fuoco se l’è portato via, come dicono succedesse agli eroi dell’antichità.
L’uomo si portava a spasso per il campo un esempio, che nel calciatore spiccava spesso per contrasto: il miracolo della dolcezza, quando si fa riconoscere in mezzo al clamore.
Ancora oggi, se vi va, chiedeteci, perché ci ostiniamo ad amare questo gioco maledetto che troppe volte si dimentica di essere tale: vi risponderemo che abbiamo visto con i nostri occhi uomini che gli hanno dato un senso che va oltre i risultati. Vi risponderemo che abbiamo avuto la fortuna di vedere giocatori come Gaetano Scirea, che hanno reso migliore il loro tempo; che anche se avessimo voluto, da avversari, fischiarli, il sibilo ci sarebbe rimasto tra i denti, attutito dal nostro rispetto.
Paolo Marcacci