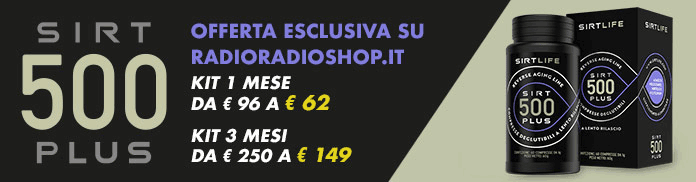Recentemente il filosofo Umberto Galimberti, autore di Psiche e Techne e di molti altri testi che hanno segnato il nostro tempo, ha detto che la parola patria è ormai morta. Lo ha detto non soltanto con il timbro diagnostico e asettico di chi registra un fatto, lo ha asserito senza alcun rimpianto, convinto che si tratti in fondo di una conquista importante. Ora, che la civiltà della tecnica e dello sradicamento planetario stia producendo il tramonto della patria è indubbiamente vero.
E non è certo il solo Galimberti a dirlo, è anzi un tema ben collaudato nella tradizione filosofica contemporanea. L’ordine dei mercati e della tecnica infatti produce sradicamento e deterritorializzazione. Si pone come il tempo della mobilitazione totale, per richiamare la celebre formula di Ernst Jünger.
E già Marx del resto, fin dal Manifesto del Partito Comunista, ci ha insegnato che il capitalismo, lungi dall’essere una realtà conservatrice, si fonda sul movimento perpetuo, sul dinamismo eracliteo, sulla trasformazione incessante e dunque sulla negazione del diritto ad avere una patria per i popoli. I proletari non hanno patria, diceva Marx, conciò riscontrando uno dei tratti fondamentali della civiltà del capitale. Ebbene, il cosmopolitismo è la figura fondamentale della civiltà della tecnica, il migrante la sua soggettività di riferimento.
Che tuttavia questo sia un destino ineluttabile, un fatto inemendabile a cui non possiamo che piegarci passivamente mi pare tesi alquanto discutibile. Nella storia umana infatti non vi è nulla di ineluttabile, da che essa resta lo spazio aperto della libertà umana e delle sue indeducibili azioni, azioni che restano appunto indeducibili da un qualsivoglia piano di necessità. scriveva il filosofo Fichte che nella storia non troveremo mai nient’altro se non ciò che vi abbiamo messo con la nostra attività libera.
Il teorema del ‘there is no alternative‘, a cui anche Galimberti in fondo sembra cedere, sappiamo bene a quale ordine del discorso rinvia. A quello di chi vorrebbe trasformare i suoi desiderati in necessità, neutralizzando l’idea stessa della possibile trasformazione e con ciò inducendo gli individui e i popoli ad accettare l’ordine delle cose non in quanto buono ma semplicemente perché dato e ineluttabile.
Perché il mondo diventa intrasformabile se ci dispensiamo dalla fatica di trasformarlo, credendo che non sia possibile fare alcunché. Insomma, bisognerebbe defatalizzare il mondo, come più volte ho detto, liberandolo da quel destino della necessità ineluttabile a cui anche Gallimberti sembra cedere. Discutibile, peraltro, mi pare anche la tesi sostenuta da Gallimberti, secondo cui sarebbe un bene la fine della patria.
Basterebbe anche solo richiamare Martin Heidegger, autore che Gallimberti conosce molto bene. Ebbene, Martin Heidegger sosteneva che nulla di grande è stato fatto dall’uomo senza un suo radicamento nella patria. Patria che, peraltro, giova a rammemorarlo, non è stata solo il luogo terribile dei nazionalismi regressivi, ma anche lo splendido spazio dei democratici movimenti di resistenza nazionale all’imperialismo, e delle fantastiche conquiste democratiche avvenute nel novecento sempre nel quadro di patrie, di stati nazionali che avevano una loro sovranità e quindi una capacità di garantire diritti e conquiste.
Insomma, per farla breve, la patria non è affatto necessariamente un concetto regressivo come l’ordine del discorso dominante vorrebbe farci credere e come lo stesso Galimberti sembra lasciare intendere quando dice che la fine della patria ormai è avvenuta e lascia intendere che ciò è qualcosa di positivo.